DALLA FECONDAZIONE ASSISTITA PER LE DONNE OLTRE I 40 ANNI FINO ALL’EUTANASIA, L’INTERVENTO DELLO STATO SI ESTENDE SU ENTRAMBE LE ESTREMITÀ DELL’ ESISTENZA. MA LA VERA SFIDA È COMPRENDERE PERCHÉ SI INTERVIENE SULLE CONSEGUENZE SENZA AFFRONTARE LE CAUSE SOCIALI ED ECONOMICHE CHE LIMITANO LA NATALITÀ.
In Italia, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) si fa carico di due aspetti cruciali dell’esistenza umana: la nascita e la morte. Da un lato, con l’ultima normativa sulla procreazione medicalmente assistita, le donne non più naturalmente fertili per ragioni anagrafiche possono accedere alla fecondazione assistita con copertura pubblica. Dall’altro, la Regione Toscana ha recentemente approvato una legge che permette il finanziamento dell’eutanasia con fondi pubblici.
Due misure che, per quanto opposte, seguono una stessa logica: lo Stato interviene laddove la natura non arriva più. Se il corpo non è più in grado di generare una vita, la scienza offre un’alternativa.

Se la vita diventa insostenibile, la società offre un’uscita regolamentata. Nulla da eccepire sul principio, ma la vera domanda è un’altra: perché lo Stato finanzia le conseguenze senza intervenire sulle cause?
L’Italia è un paese dove i giovani raggiungono l’indipendenza economica sempre più tardi, spesso oltre i 40 anni. Questo è il vero freno alla natalità. Non è solo una questione biologica: le donne rimandano la maternità perché non possono permettersi di avere figli prima. Così, quando il tempo biologico si esaurisce, interviene la scienza, con costi a carico del SSN.

Se lo Stato si impegna a garantire la possibilità di diventare genitori anche dopo la fertilità naturale, perché non investire prima, creando condizioni economiche che permettano alle persone di fare figli in età giovanile, come natura vorrebbe?
La soluzione non può limitarsi a interventi di tipo medico. È necessaria una politica sociale che favorisca l’indipendenza economica dei giovani entro i 30 anni. E qui entrano in gioco i sindacati, che possono fare da ponte tra Stato e società, promuovendo una politica contrattuale più inclusiva per le nuove generazioni.
La Confederazione Nazionale Conapi si è già espressa su questa necessità e intende impegnarsi attivamente per sostenere una politica sindacale che renda i giovani autonomi economicamente prima dei 40 anni.
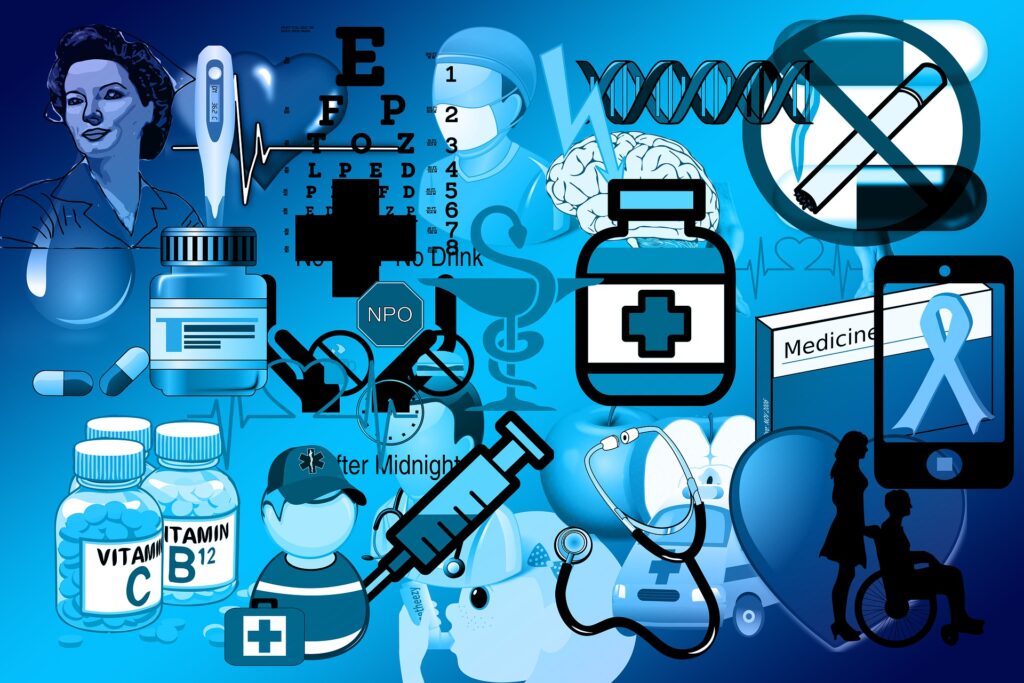
Questo significa promuovere contratti più stabili, salari adeguati e un accesso al mondo del lavoro che non costringa a decenni di precarietà.
Sostenere la natalità attraverso la fecondazione assistita e garantire il diritto a una morte dignitosa sono temi su cui il dibattito morale è aperto. Ma il vero punto è che queste misure restano soluzioni a posteriori.
Forse, prima di finanziare la scienza per risolvere i problemi creati dal sistema sociale ed economico, bisognerebbe cambiare quel sistema stesso. E su questo, più che la medicina, dovrebbero intervenire la politica e il mondo del lavoro.





